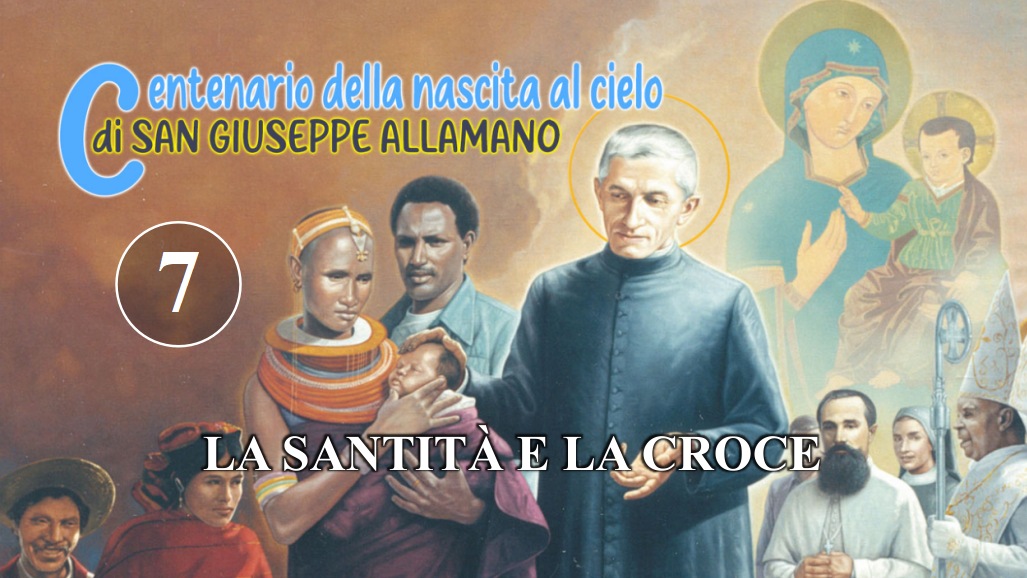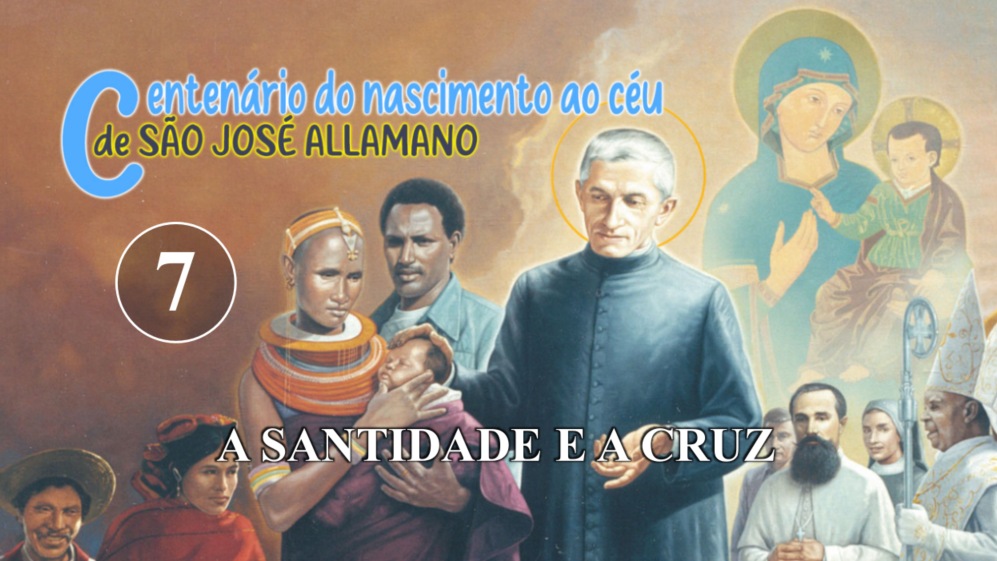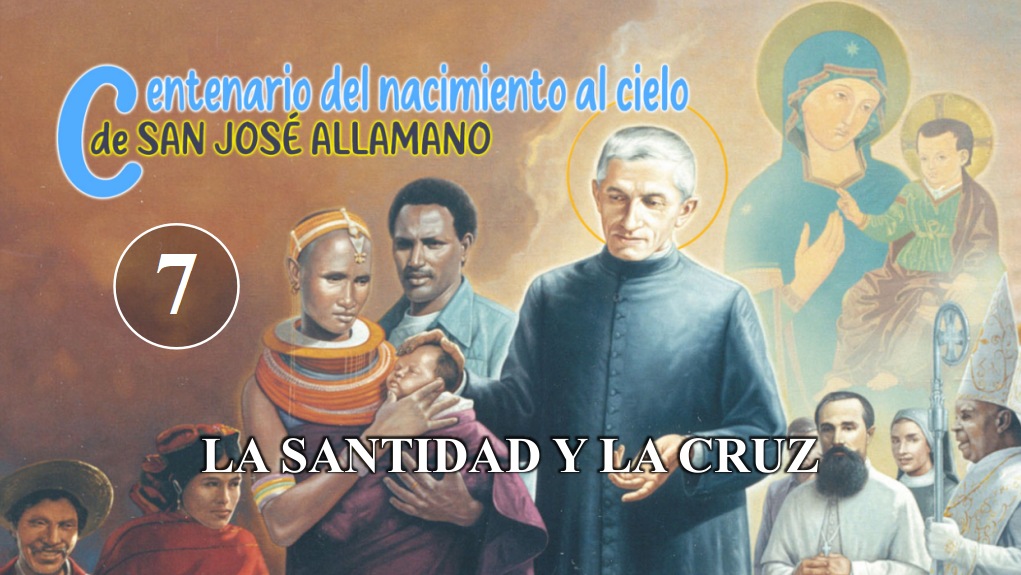Per una volta, abbiamo chiesto di tenere insieme la riflessione del mese scorso e quella di questo mese. In entrambi i casi ci concentriamo sul profeta Geremia. Là eravamo andati a rileggere il capitolo 20, tormentato e straziante, con il profeta che si rammaricava per ciò che doveva annunciare e che si riprometteva di tacere, ma senza riuscirci. Un profeta che si scopriva in contrasto con Dio, che sperava di non ascoltare più.
Quella tristezza e angoscia lasciano tuttavia lo spazio a un sogno ben diverso, pochi capitoli più in là, in quelli che sono il cuore del messaggio di Geremia.
Il contesto
Geremia vede la distruzione del suo popolo, del tempio, della città santa. Viene chiamato da Dio ad accogliere questa catastrofe come un bene, come il volere divino. È lo stesso profeta a ribellarsi a volte a questo annuncio così duro. Dalla distruzione, però, emerge un barlume di bene, che progressivamente si fa più grande. La sorte del popolo non è la morte, la sua distruzione non segna la fine.
Nella parte centrale del libro, la più importante, Geremia invita i deportati a cercare il bene del territorio nel quale sono stati deportati, a comprare case ed abitarle, a riprendere a vivere. E intravede un futuro in cui Israele sarà ricondotto alla sua patria, «liberandolo dalle mani di uno più forte di lui» (Ger 31,11).
Con uno scarto umanissimo, delicato e poetico, Geremia ritorna ad evocare il pianto, che dice di sentire da Rama, la località in cui si immaginava fosse morta Rachele, madre di Giuseppe e di Beniamino, ossia i capostipiti del cuore del popolo (da Giuseppe nasceranno Efraim e Manasse, e quelle tre tribù spesso sono citate come riassunto dell’intero popolo ebraico). Ma l’evocazione così delicata e accennata del pianto sui propri figli viene smentita dalla promessa che «c’è una speranza per la tua discendenza: i tuoi figli ritorneranno nella loro terra» (v. 17).
Il migliore sogno profetico
Le parole si fanno sempre più coraggiose, Geremia sogna un ritorno di tutti i discendenti di Giacobbe nella loro terra, per abitarla nella pace e nell’abbondanza: «Verranno giorni nei quali renderò la casa di Israele e la casa di Giuda feconde di uomini e di bestiame» (v. 27). «Come ho vegliato su di essi per sradicare e per demolire, così veglierò su di loro per edificare e per piantare» (v. 28).
Un Dio che ritorna a prendersi cura del benessere dei suoi figli, la promessa di una restituzione nazionale che è anche di rapporto con il loro Signore.
È un sogno diffuso tra i profeti, che quell’armonia tra Dio e il suo popolo che si immaginava ci fosse stata nei tempi antichi (benché anche questa fosse un’illusione), possa tornare a esistere senza angosce, senza paure, in piena serenità.
È per questo sogno che diversi profeti sono stati capaci di uscire dalla logica di una retribuzione per clan, dove contava innanzi tutto l’appartenenza al gruppo, secondo i modi di pensare dell’antica cultura semita. Era stata questa la spiegazione che molti ebrei si erano dati della distruzione: “Noi non siamo peggiori dei nostri antenati, ma sono loro ad aver peccato allontanandosi da Dio, il quale oggi punisce il nostro gruppo”. Peccato che questa interpretazione rinunciasse al valore delle scelte del singolo, riconducesse tutto ad un ambito tribale che non è personale, non è propriamente biblico pur trovandosi molto nella Bibbia.
Sono stati quindi diversi i profeti che si sono sentiti in dovere di correggere quell’impostazione: «Non si dirà più: “I padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli hanno sentito il tannino”» (v. 29). Ognuno sarà responsabile per le proprie azioni.
Era già tanto: il ripristino dell’antico popolo, la responsabilità affidata a ognuno. Molti profeti arrivano fin qui, ed è già moltissimo, è confermare la fedeltà divina nonostante la catastrofe, e valorizzare la dimensione del singolo.
Ma Geremia va oltre.
Un sogno ulteriore
«Ecco verranno giorni…»: così Geremia introduce una dimensione ulteriore. Guarda il futuro, lo legge dentro il cuore di Dio, e sogna insieme a lui.
Geremia, o Dio, sogna un’alleanza nuova (v. 31), diversa da quella conclusa ai tempi di Mosè. L’affermazione è già pesante. La tradizione ebraica insiste molto sulla memoria come fondamento per il futuro: vale la pena fidarsi di Dio perché si è mostrato affidabile in passato, con una dinamica che è di relazione personale, in quanto è con gli amici che mi regolo in questo modo, non con un trattato. Eppure Geremia ha il coraggio di stravolgere questa convinzione: l’alleanza con il popolo sarà qualcosa di nuovo. Il vecchio accordo è stato violato dagli uomini, ma Dio ha intenzione di rifarne uno nuovo, diverso.
Di fronte alla rottura della fiducia, Dio decide di non rispondere con giudizio o sfiducia, ma di rilanciare, come un innamorato che, di fronte al tradimento del partner, sceglie di non rompere la relazione né di ritornare come prima, come se non fosse successo niente, ma di rilanciare con qualcosa di più radicale e profondo.

L’alleanza sognata da Dio
Il nuovo patto sognato da Dio non viene spiegato nei contenuti, ma nella modalità: un’alleanza «scritta sul cuore» (v. 33). Per noi il cuore è la sede dei sentimenti, a volte in lotta con la testa, che è la razionalità. Per il mondo semita la sede delle emozioni sono invece le viscere (alla lettera, “l’utero”). Il cuore è il luogo in cui la passione media con la ragione, e i due si mettono in dialogo per arrivare a delle decisioni. È il luogo più equilibrato dell’essere umano, nella convinzione che non sia sufficiente la razionalità, ma che anche l’emotività, da sola, non aiuti a vivere bene: c’è bisogno che i due elementi si ascoltino, si parlino, decidano insieme.
Una legge divina scritta nel cuore lascia pensare a un essere umano che sa come restare fedele a Dio. Non per istinto o per ragionamento, ma nel modo più umano possibile, che pone insieme passione e intelligenza. Là dove l’uomo è più autenticamente se stesso, Dio verrà incontrato, a garanzia di un’umanità che non è diversa dal divino ma anzi si compie pienamente insieme a lui.
Ecco perché non ci sarà più bisogno di istruirsi a vicenda nella legge di Dio, come occorreva fare nella vecchia alleanza, utilizzando la testa. In questo nuovo patto l’essere umano, quando penserà con calma alle proprie decisioni, sceglierà secondo il cuore di Dio.
Non ci saranno quindi più mediazioni, non ci sarà bisogno di sacerdoti o una legge, perché tutti saranno profeti, capaci di cogliere che cosa farebbe Dio, e conformarsi a quelle valutazioni. Un sogno di questo tipo prevede di abolire il sacro distinto dall’umano, di mescolare Dio e uomo in un’unione inscindibile. È esattamente ciò che accadrà in Gesù e che il Padre sogna per ogni essere umano.
A questo punto, la reazione divina non sarà semplicemente di perdonare la colpa, ma, più radicalmente, che «non ricorderò più il loro peccato» (v. 34). Scopriamo così che Dio non vuole dei sudditi ubbidienti, ma degli innamorati, capaci di inventare e intuire, decidere e camminare. Un’umanità adulta che non ubbidisce più ad alcuna legge, perché coglie quali decisioni sono quelle che fanno vivere bene. Un’umanità innamorata di Dio e a cui Dio non può neanche immaginare di smettere di voler bene.
Questo è il sogno di Dio. Questo è ciò che accadrà agli esseri umani che vorranno scommettere su questo sogno.
Angelo Fracchia