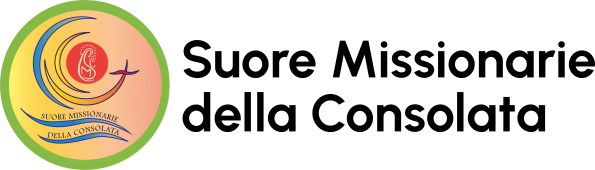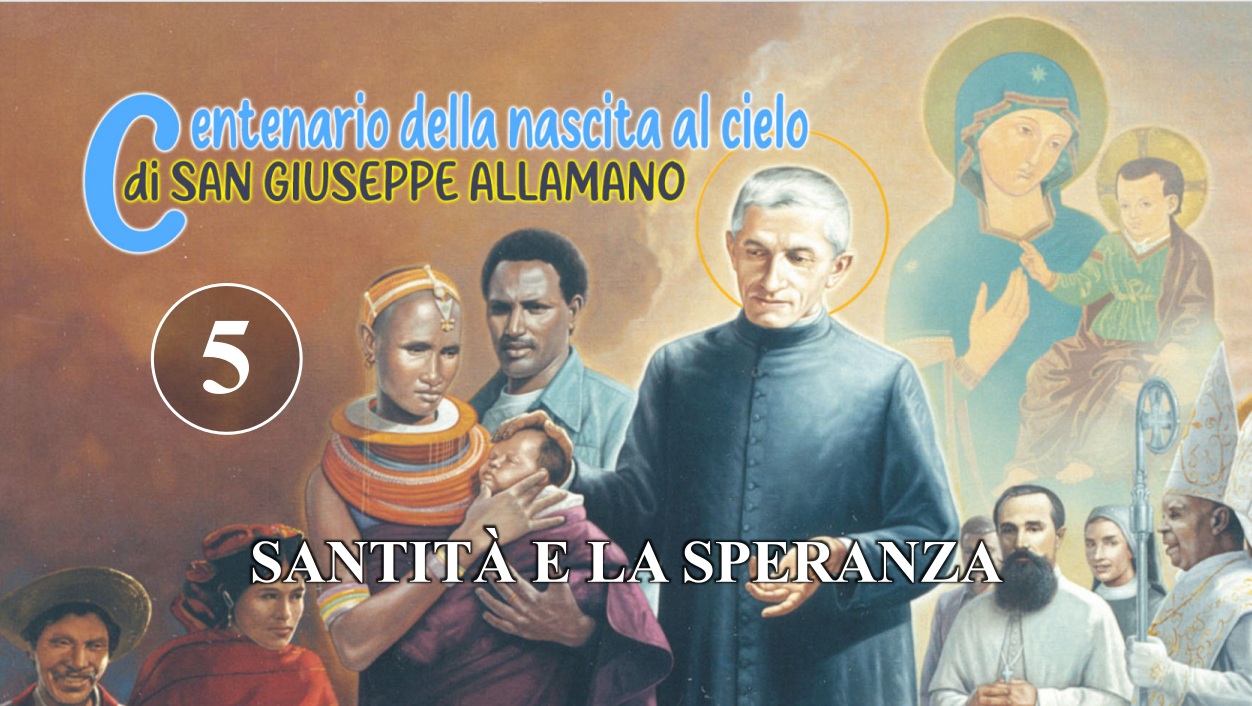In Tanzania, nella città di Iringa, le Suore Missionarie della Consolata accolgono nella “Casa della gioia” ragazze che provengono da situazioni familiari difficili o sono orfane. Le minori sono affidate alle cure delle Suore e delle educatrici fino al termine della scuola secondaria, ma l’accompagnamento continua fino a quando la giovane trova un lavoro dignitoso. Nella Casa della Gioia, da sempre le ospiti, al loro inserimento sono avviate al lavoro manuale domestico e nella coltivazione dell’orto, come avviene nelle normali famiglie tanzaniane. Tuttavia, per l’innalzamento dei costi e pensando al futuro delle ragazze, nel 2024 si è lanciato un progetto per l’allevamento intensivo di polli, galline ovaiole, maiali e conigli, con l’obiettivo di insegnare un mestiere alle ospiti, ma anche pagare le spese della Casa. Suor Paskalina, che segue la Casa della Gioia, ed era responsabile del progetto, aveva indicato la somma di 5.320,00 euro, con i quali: – costruire gli ambienti per l’allevamento – comprare gli animali – comprare il mangime per i primi tempi e i vaccini “Per costruire il pollaio, acquistare pulcini e conigli e un primo rifornimento di mangime e di vaccinazioni avremmo bisogno della grande generosità dei benefattori nei quali confidiamo e offriamo la nostra preghiera, delle bambine e delle giovani che aspirano ad una vita indipendente e dignitosa”. La generosità non è venuta meno, ed ecco che non solo si raggiunge la somma proposta, ma la si supera abbondantemente: 6.850,00 euro! Con lettera del 30 giugno 2025, Suor Paskalina si rivolge ai sostenitori del Progetto: Iringa, 30/06/2025 Carissimi amici, Veniamo a voi per ringraziarvi per aver finanziato il progetto di allevamento per la “Casa della Gioia” di Iringa. Sono già nati 5 maialini. Dall’allevamento abbiamo carne e uova per la nostra alimentazione. I conigli non ci danno tanta soddisfazione perché i piccoli muoiono dopo tre mesi di vita, stiamo cercando la causa. Vi ringraziamo per la vostra offerta generosa, il Signore continua a benedirvi nelle vostre attività. Suor Paskalina Ecco qui alcune foto dell’allevamento in piena attività! Il progetto è stato così positivo che per il 2025 le Sorelle lo hanno riproposto per le famiglie, come si può vedere cliccando qui GRAZIE DI CUORE PER AVERE SOSTENUTO IL PROGETTO DEL “POLLAIO PER LA CASA DELLA GIOIA”!
La gioia di un apostolo: Paolo e il capitolo 8 dei Romani
Nel Nuovo Testamento a scrivere più lettere è stato Paolo di Tarso. Non che scriva sempre, di solito lo fa quando è preoccupato o arrabbiato. Poi, certo, di tanto in tanto anche lui scrive da disteso e sereno. Capita ad esempio nell’intera lettera ai Filippesi, ma anche nel capitolo 8 della lettera ai Romani. Questa di per sé è una lettera scritta per giustificare il suo stile di annuncio, quindi ben delicata, ma, arrivato a quel punto, Paolo ritiene evidentemente di aver fatto un buon lavoro, di avere efficacemente dimostrato che noi siamo in armonia con Dio semplicemente perché Dio vuole così, ci vuole suoi amici ed è disposto a perdonarci tutto. Finalmente, Paolo si rilassa e si scioglie in uno dei più begli inni della Bibbia. Questo mese è praticamente Paolo a parlare (o almeno, lo si può seguire passo passo). Spirito e carne Chi è in Cristo non è condannato (Rom 8,1). In passato si era cercato di compiere la volontà di Dio, la legge, con le proprie forze umane, con la “carne”, ma questo era impossibile, (8,3) perché era impossibile che un uomo si comportasse esattamente come Dio voleva e dunque si “meritasse” la sua amicizia. Dio ha però deciso di mostrare nel suo Figlio uno stile diverso (8,4): non si tratterà di essere perfetti, ma di lasciarsi permeare dallo Spirito di Gesù, di vivere come lui (8,5). Vivere secondo la carne (8,6), in questo contesto, non vuole allora dire vivere nel peccato sessuale (la Chiesa spesso l’ha interpretato così), ma vivere pensando che ciò che facciamo ci guadagni l’amicizia di Dio, con strumenti umani, carnali. Paolo è convinto di essere riuscito a dimostrare che siamo in armonia con Dio, cioè salvi, grazie al suo dono gratuito e al nostro fidarci di quel dono, ossia tramite la grazia e la fede. In Gesù scopriamo che anche Dio preferisce un’adesione a lui non formale, non fatta di perfezione ufficiale, ma sostanziale, di fiducia (8,7-8). In fondo, anche noi, quando siamo in relazione con qualcuno, siamo disposti a passare sopra ai difetti involontari, agli errori, ma chiediamo fiducia e dono di sé. Non sopporteremmo qualcuno perfetto ma che non sembra desiderare di stare con noi. Se però i nostri amici stanno volentieri con noi e noi con loro, passiamo sopra a tante imperfezioni! Dio spera nella nostra fiducia perché non ci pensa come servi ma come amici, anzi addirittura come figli Chi cammina nello Spirito è figlio di Dio Non resta quindi che vivere secondo lo Spirito, senza pensare alle “opere della carne” (vale a dire senza pensare di fare il bene perché è stato ordinato, così che Dio ci premi: 8,12-13). Se Dio ci chiama figli, è perché è con noi in una relazione intima, profonda, che non dipende dal fatto che facciamo o non facciamo il nostro dovere (8,14), ma dall’accoglierne l’amore gratuito, come un figlio che viene amato senza fare niente per meritarselo e prima di qualunque azione; al limite, il figlio potrà rispondere in modo adeguato a quell’amore. Questo è ciò che ci dice il vangelo, per quanto sia sorprendente: Dio ci ama, comunque. Ma davvero questo è possibile? Davvero siamo figli di Dio? È di nuovo Gesù a dircelo, a farci pregare chiamando Dio come “Padre” (8,15), e in fondo lo sentiamo con la voce dello Spirito che parla dentro di noi. Ma qualcuno dirà che siamo figli di Dio nel senso che veniamo da lui, che lui ci ha creati. No, dice Paolo! Siamo figli veri, anche se adottivi: se per assurdo il Padre dovesse morire, ci divideremmo l’eredità con Gesù (8,17), perché siamo figli come lui, anche se noi non lo siamo per natura ma per adozione. Per questo non soffriremo per sempre. La sofferenza odierna Ancora, ma come è possibile? Davvero siamo figli di Dio? Noi soffriamo, siamo infelici, siamo incompleti. Come è possibile che Dio ci voglia così? In realtà, non c’è paragone tra la nostra sofferenza di adesso e la forma che assumeremo in futuro (8,18). Saremo felici, saremo nuovi, nuove creature. Anzi, è la creazione stessa, come noi, che aspetta con ansia che noi diventiamo pienamente figli di Dio (8,19: l’immagine del verbo greco è di chi allunga il collo per anticipare anche solo di un secondo la visione di chi sta arrivando). Anche la creazione, infatti, non resta immutata per sempre, bensì marcisce, muore, e spera che il nostro diventare perfetti segni finalmente anche il suo restare viva per sempre, insieme a noi, che siamo i figli prediletti di Dio e che porteremo la creazione insieme con noi in paradiso (8,20-21). Finora, però, tanto la creazione quanto noi non siamo ancora perfetti. È come se dovessimo ancora nascere (8,22). Nel parto c’è una sofferenza e un’incompiutezza che sembrano senza fine, ma che aprono la strada alla vita. Come un bambino nel grembo della madre, noi viviamo già, siamo già figli di Dio, ma in realtà non lo siamo ancora pienamente. Lo speriamo, lo intuiamo, lo prospettiamo, ma non lo abbiamo ancora del tutto. Il bimbo nel grembo è già una vita, ma non è ancora nato, anche se naturalmente nascerà e sarà autonomo. Così accadrà anche noi, e insieme a noi salveremo, rimetteremo in dialogo con Dio, anche la natura, che, dice Paolo, è come se non vedesse l’ora che noi diventiamo perfetti, per diventarlo anche lei con noi (8,23-24). C’è di più: noi abbiamo accanto lo Spirito Santo, che prega con noi. Non perché lo Spirito sappia di che cosa abbiamo bisogno; probabilmente, invece, non lo sa neanche lui e non riesce ad esprimersi in modo compiuto (8,26). Il Padre però accoglie, ascolta, e compie il bene di chi è dalla sua parte, in quanto è esattamente ciò che lui vuole (8,27). È un’immagine inattesa, quello dello Spirito Santo, della presenza stessa di Dio nella nostra storia, che non sa bene di che cosa abbiamo bisogno, ma si mette al nostro fianco, gemendo come un animale che non sa come spiegare il proprio desiderio. Ma
MONDO ALLAMANO: Ad gentes ad alta quota
Le Missionarie della Consolata con il popolo quechua in Bolivia C’è abbastanza carburante nella Jeep (negli ultimi tempi, non sempre è così…) e le Missionarie di Vilacaya (piccolo paesino a 3.000 metri di altitudine sulle Ande boliviane) decidono di andare a visitare due famiglie che vivono in borgate a circa 10 km di distanza. Il veicolo sobbalza, superando pietre e buche, mentre alza il polverone dietro di sé. Entrambe le famiglie vivono in case dipinte di bianco e azzurro, costruite da un progetto del governo, il cui Partito si contraddistingue proprio per questi due colori. Entrambe sono composte da due genitori e sei figli, più o meno della stessa età, entrambe lottano per assicurare un oggi e un domani ai piccoli di casa. Non è facile: Vilacaya, e in generale il sudovest della Bolivia è colpito da una progressiva siccità, che rende quasi impossibile la vita delle famiglie contadine, appartenenti all’etnia quechua. Ci sono anche differenze: la prima famiglia cerca con tutti i mezzi di migliorare le sue condizioni, mentre la seconda è prostrata anche dalla piaga dell’alcolismo, e alle volte i bambini soffrono l’abbandono. Ma anche questa è una faccia della povertà. Il primo amore: Poopó e i minatori Le Missionarie della Consolata sono approdate in Bolivia nel 1991, ma se ne sono “innamorate” molto prima: nel 1989 due Consigliere generali – Suor Renata Conti e Suor Evelia Garino – visitarono diversi Paesi dell’America Latina, in vista di una nuova presenza missionaria accanto ai popoli nativi. Passarono a Poopó, centro minerario del Dipartimento di Oruro e ne rimasero profondamente toccate. Come Istituto, però, si scelse un’apertura a Tencua, nell’Amazzonia venezuelana. Succede. Ma la storia non finì nel nulla: la Direzione generale propose alle Sorelle presenti in Argentina di riflettere su una possibile apertura a Poopó. E questa avvenne, appunto, nel 1991. Quella di Tencua, come quella di Poopó, è stata una risposta all’opzione che, gradualmente, le varie presenze delle Missionarie della Consolata nel Continente americano hanno fatto propria: la scelta della missione ad gentes tra i popoli indigeni e originari. All’epoca, il “movimento indigenista”, appoggiato da ong e da Chiese di varie denominazioni, era molto attivo e rivendicava i propri diritti. Fu un tempo intenso, nel quale la presenza dei Missionari e delle Missionarie della Consolata si concentrava nell’impegno per la Giustizia e la Pace, e in progetti di promozione umana. “Era chiaro che la nostra presenza non doveva essere una risposta assistenzialista” ricorda Suor Marisa Soy, una delle prime missionarie giunte in Bolivia. La situazione socio economica dell’altipiano andino, all’inizio degli anni Novanta, era preoccupante: la speranza di vita era bassa e la mortalità infantile molto frequente. Le Sorelle iniziarono a visitare le famiglie per rendersi conto della condizione reale della gente. A livello di Chiesa, già esisteva un’equipe diocesana di Pastorale sociale, quindi la collaborazione fu immediata e molto positiva. “Conoscevamo i progetti dell’equipe, contribuivamo con il nostro lavoro e anche economicamente” condivide Suor Marisa. Oltre all’impegno sociale, le Sorelle partecipavano alle Comunità di Base e accompagnavano la Pastorale Giovanile. Vilacaya: tra i contadini quechua Dopo 20 anni di presenza, nel 2012 la riflessione porta a un “cambio di domicilio”: la Parrocchia di Poopó ha i suoi leaders, le condizioni socioeconomiche della cittadina sono migliorate. La sfida di lasciare terreni dissodati e conosciuti, per ricercarne altri e iniziare da zero (o quasi) fa parte della missione ad gentes. Con le lacrime agli occhi, ma con nel cuore tanta gratitudine per la missione vissuta, nel 2013 si chiude la comunità di Poopó e si apre quella di Vilacaya, nel Dipartimento di Potosí, una vasta regione del sud del Paese, in cui la presenza ecclesiale è quasi nulla. L’opzione per i popoli indigeni dell’Istituto ha compiuto passi significativi nel tempo. Oggi si dà molta attenzione allo studio della cultura, della lingua e della spiritualità del popolo nativo, come riconosce Suor Marisa che, dopo una ventina d’anni vissuti fuori Continente, è ritornata in Bolivia, questa volta a Vilacaya: “Qui ho percepito un impegno maggiore della comunità delle Missionarie nel conoscere la cultura e accompagnare la gente nella riflessione sulla propria identità. E’ bello che protagoniste siano le persone e noi delle Sorelle che le accompagniamo”. Con molto sforzo e convinzione, i popoli andini cercano di armonizzare le proprie radici originarie, la fede cristiana e le sfide del mondo globalizzato (paradigmi culturali nuovi e attraenti, il cambio climatico, le politiche nazionali). Suor Nadia Leitner ha vissuto diversi periodi in Vilacaya, fin dai primi passi nella formazione iniziale. Oggi è la sua Chiesa di origine, in Mendoza (Argentina) ad averle dato il mandato per la missione in Bolivia: “Questo mandato è un segno di fiducia e speranza, la certezza che non sono sola, e che non cammino per conto mio” ci racconta Suor Nadia. “Per me significa vivere l’ad gentes del Continente America. Vivere con il popolo quechua ha tanto da insegnarmi”. Vilacaya, oggi Suor Marisa, Suor Nadia e Suor Maria Elena rientrano dalla visita alle due famiglie con il cuore colmo di emozioni e interrogativi: Che ne sarà di questi bambini, in un ambiente così sfidante? Saranno migranti, come tanti altri, alle periferie delle città, o nei cunicoli delle miniere? Non ci sono risposte a queste domande, ma c’è una risposta all’oggi di queste persone: la presenza delle Suore e la visita che fanno alle comunità e famiglie, che reca sempre tanta gioia. Si percepisce molta solitudine e senso di abbandono nella popolazione quechua della zona. “Oggi Dio mi sta chiedendo di stare qui, dare il meglio di me, perché ogni persona possa sentirsi amata da Dio, un Dio che non si dimentica dei suoi figli. Condividere la vita con la gente, significa dire loro che sono persone che hanno valore, che i loro sogni valgono” Dice Suor Nadia. E questa è la consolazione che fa vivo e presente lo spirito di San Giuseppe Allamano nella vita delle sue figlie. Anche ad alta quota. Suor Stefania, mc Questo articolo è stato pubblicato dalla Rivista Missioni Consolata. Puoi scaricarlo qui:
La Donna della Risurrezione
Testo: Gv. 20,1-18 1 Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. 2 Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!”. 3 Uscì allora Simon Pietro insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. 4 Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5 Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 6 Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, 7 e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. 8 Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 9 Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. 10 I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. 11 Maria invece stava all’esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro 12 e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. 13 Ed essi le dissero: “Donna, perché piangi? ”. Rispose loro: “Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto”. 14 Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. 15 Le disse Gesù: “Donna, perché piangi? Chi cerchi? ”. Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: “Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo”. 16 Gesù le disse: “Maria! ”. Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: “Rabbunì! ”, che significa: Maestro! 17 Gesù le disse: “Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma và dai miei fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”. 18 Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: “Ho visto il Signore” e anche ciò che le aveva detto. I quattro Vangeli concordano tutti su un dettaglio di vitale importanza che riguarda la mattina di Pasqua: nelle prime ore del giorno, quando era ancora buio, le donne andarono alla tomba di Gesù. I particolari su quella visita mattutina, variano da Vangelo a Vangelo, ma la presenza delle donne è un dato costante. Come avviene con la presenza delle donne alla crocifissione di Gesù, la tradizione non si pone domande su questa ulteriore dimostrazione di fedeltà da parte loro. La accetta semplicemente come una parte essenziale della storia della risurrezione. L’episodio di Maria Maddalena nel cap. 20 di Gv. è il più dettagliato dei quattro racconti sulle donne al sepolcro di Gesù. Sì divide in due scene: 20,1-10: Maria alla tomba vuota. 20,11-18: Maria e Gesù risorto. Primo momento: I vv. 20,1-10 affermano che Maria è la prima testimone della tomba vuota. Quando vi giunge, lei vede che la pietra che chiudeva il sepolcro è stata fatta rotolare via (20,1). Si mette a correre e da la notizia a Pietro e al discepolo prediletto (20,2). Fa presente quella che sembra essere l’unica spiegazione logica dei fatti: qualcuno ha portato via dalla tomba il corpo di Gesù e non lo si ritrova. L’angoscia di Maria rispecchia lo sconvolgimento del mondo per la tomba vuota: ancora oggi tanti studiosi ed esegeti discutono su questo dato di fatto. Finché la comunità non incontra Gesù risorto non vi sono categorie con cui comprendere la tomba vuota Sulla base delle parole di Maria, Pietro e il discepolo prediletto corrono al sepolcro (20,3-4), entrano all’interno (20,5-8), ma si conosce soltanto la reazione del discepolo che Gesù amava. Il v. 8 afferma che egli: «vide, e credette». La sua fede è soltanto agli inizi infatti il racconto prosegue dicendo che non sapevano ancora della risurrezione (20,9). I discepoli maschi, come Maria, non trovano parole nelle loro esperienze precedenti per descrivere la tomba vuota. Maria ha reso testimonianza al mistero perfino nella sua angoscia, mentre Pietro e il discepolo prediletto sono rimasti silenziosi e ritornano al loro mondo di paura. Il Secondo momento (20,11-18) ha inizio con Maria che si ritrova di nuovo alla tomba, sola e in lacrime. Lei non ha paura, lei ama e rimane fedele anche nel buio e nel non senso delle situazioni, anche quando tutto sembra smarrirsi e perdere significato. Come Pietro e il discepolo prediletto prima di lei, ella ora si china a guardare nel sepolcro. Chinarsi, in greco è un verbo che esprime l’attitudine di chi entra nel mistero, quasi a significare che Maria è sollecitata ad entrare nella fede, e ad accogliere la pasqua del Cristo, anche se non vede, anche se non comprende. In questo suo chinarsi a guardare il sepolcro vuoto, Maria si sente interpellata da due angeli, che le dicono: «Donna, perché piangi?» (20,13). L’appellativo «donna» è lo stesso termine che sarà usato da Gesù risorto per parlare a Maria in 20,15. Gli Angeli chiamandola “Donna” richiamano la sua identità più profonda e Maria guardando la tomba vuota risente la voce del maestro quando a era entrata nella casa di Simone per ungere il corpo di Gesù (Lc.7,36-50). La donna del profumo in Luca 7 entra in scena in veste di emarginata, esclusa dal mondo sociale, dal sistema religioso, dal banchetto, dalla tavola, dal dialogo. Essa non ha nome, cultura, prestigio, influsso, autorità e, sicuramente, non dispone neppure di molti mezzi economici. La donna del profumo ha soltanto l’ardire e l’audacia di sfidare le strutture più potenti della società del suo tempo. Essa è sola. È peccatrice e lo sa. Gode di cattiva reputazione e lo sa. Non fa assegnamento su alcun gruppo di appoggio;
Santità e speranza – San Giuseppe Allamano
Verso il Centenario della nascita al Cielo di San Giuseppe Allamano, i suoi figli e figlie si radunano attorno a Lui per ascoltare ancora una volta i suoi insegnamenti. Oggi sulla speranza e la santità. “Paolo era un pescatore solitario che viveva in riva al mare. Dopo aver perso la moglie, non era mai più andato a pescare con la sua barca. Le giornate passavano lente, e non aveva più senso per lui solcare le onde che amava tanto. Una notte d’inverno una forte tempesta si abbatté sul piccolo villaggio: i venti urlavano e le onde erano come mostri furiosi. Paolo guardò tutto attraverso la finestra, finché, tra i lampi e i tuoni, vide una piccola luce lampeggiare in lontananza. Era il faro che rimaneva acceso, fermo, nonostante tutto il caos che lo circondava. La mattina dopo, apprese che una barca di giovani pescatori si era persa in mare e che era stata la luce del faro a guidarli verso la riva. Il giorno dopo, qualcosa è cambiato. Pulì la sua vecchia barca, sistemò le vele e al tramonto andò a pescare. Paolo ha capito che, a volte, la speranza è proprio questo: una piccola luce accesa nella tempesta.”. Questa piccola storia ci aiuta a capire che la speranza non elimina la tempesta, ma indica una strada, non richiede grandi certezze, ma solo piccoli passi verso la certezza. Nel mondo di oggi, circondato da crisi e disperazione, la speranza non è un lusso, è una necessità vitale. E, come il faro per i naviganti, rimane fermo, acceso, invitandoci a continuare, anche quando tutto sembra perduto. La parola speranza porta in sé un silenzioso dinamismo. In latino, spes significa “fiduciosa attesa”, ed è legato al verbo sperare (aspettare con fiducia). In greco, la parola corrispondente è elpís (ἐλπίς), che si riferisce anche all’attesa, ma con una connotazione più esistenziale: una fiducia rivolta al futuro, spesso oltre il visibile. Papa Francesco, in questo Anno Giubilare, ci ha invitato a vivere la nostra fede come un cammino, ricordandoci che la vita cristiana è un continuo pellegrinaggio verso Dio. La speranza, in questo contesto, non è semplicemente ottimismo o desiderio di un futuro migliore, ma virtù teologale basata sulla certezza che Dio è fedele alle sue promesse: «Noi, che abbiamo cercato rifugio in lui, abbiamo un forte incoraggiamento ad afferrarci saldamente alla speranza che ci è proposta. In essa infatti abbiamo come un’àncora sicura e salda per la nostra vita: essa entra fino al di là del velo del santuario, dove Gesù è entrato come precursore per noi» (Eb 6,18-20). È un invito forte a non perdere mai la speranza che ci è stata donata, a tenerla stretta trovando rifugio in Dio”. San Giuseppe Cafasso, modello di speranza San Giuseppe Allamano additava allo zio Giuseppe Cafasso un modello di speranza che tutti i suoi missionari dovevano seguire: “Aveva tanta speranza infondere anche negli altri. Quando gli si diceva che la porta del paradiso è stretta, rispondeva: «Ebbene, passeremo uno alla volta!». Infondeva la speranza anche nei condannati a morte, dando loro le commissioni per la Madonna e, dopo l’esecuzione, esclamava: «Un santo in più!». E soggiungeva anche: «Quei birbanti ci rubano il paradiso!»… Dunque sperare, fortemente sperare!” La speranza non è solo una virtù teologale astratta, ma una forza concreta che dà senso e orientamento alla vita, anche nelle situazioni più drammatiche, come l’approssimarsi della morte. Siamo invitati a vivere una speranza attiva, contagiosa, piena di fiducia nell’amore di Dio, cioè, come missionari, siamo chiamati ad essere fonti di speranza per gli altri, anche (o soprattutto) quando tutto sembra perduto. La fiducia: la speranza più pura Nella sua spiritualità, Giuseppe Allamano ci parla della fiducia come della forma più alta della speranza, la sua “quintessenza”. La parola “quintessenza”, che deriva dal latino quinta essentia, suggerisce tutto ciò che c’è di più puro, di più essenziale: dobbiamo confidare in Dio al di sopra delle nostre debolezze, al di sopra delle nostre cadute, al di sopra della nostra logica umana. C’è nella nostra vita un eterno conflitto tra il non fare nulla e la grandezza della nostra vocazione missionaria, ma non scoraggiamoci perché questa è un’esperienza comune tra coloro che cercano di vivere autenticamente il Vangelo: si sentono indegni, incapaci, scoraggiati. Ma la risposta non sta nell’arrendersi, ma piuttosto nell’immergersi più a fondo nella fiducia. Un missionario senza fiducia diventa “un tormento per se stesso e per gli altri”. Senza fiducia non c’è gioia, e senza gioia non c’è Vangelo che possa essere trasmesso. La fiducia non è quindi solo una virtù teologale, ma un dovere apostolico perché è contagiosa, genera pace e porta frutto: “Amo la preghiera sulla fiducia in Dio: un giorno te la porterò”. Non perderò mai la fiducia in Te, mio Dio. Oh, com’è bello!” Questa fiducia ha bisogno di essere coltivata, alimentata e condivisa. Il Salmo 124 – “Quelli che confidano nel Signore sono come il monte Sion: esso non vacilla, rimane saldo per sempre” – ci esorta a possedere questa fermezza perché essa sarà il fondamento della nostra Missione! La speranza nell’essere missionario La speranza trasforma profondamente la vita del missionario, portandolo a vivere con spirito nuovo e pasquale, cioè a vivere alla luce della Pasqua di Cristo, coltivando un nuovo modo di essere, di pensare, di agire e di relazionarsi con Dio, con gli altri e con la propria storia. Qui presento alcune delle sfide che San Giuseppe Allamano ci presenta, sempre ancorate alla speranza: – Essere missionari nuovi e pasquali che vivono con una prospettiva rinnovata, senza paura della storia o del futuro, sempre aperti alla novità del Risorto: “Non dire dunque: «Chi sa se mi salverò?», ma: «Voglio salvarmi e quindi voglio emendarmi dei miei difetti e non scoraggiarmi»”. – Essere missionari contemplativi e poveri, capaci di riconoscere Dio nei deserti della vita, radicati nella storia ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro: “Ora, quando si cammina alla presenza di Dio, si fanno le cose bene, con perfezione”. – Amare il proprio tempo vivendo fedelmente il presente, l’“ora” che ci è
Il potere davanti a Dio: la lezione nascosta di Luca 23
Il mondo biblico è solitamente abbastanza diffidente nei confronti del potere. È vero, l’immagine della presenza definitiva di Dio nella storia è legata a Davide (dapprima come re ideale, poi come modello del re messianico), ma in fondo anche la monarchia viene narrata non come una scelta di Dio, ma come una richiesta del popolo a cui il Signore, un po’ controvoglia, acconsente. E dai poteri internazionali Israele è stato minacciato, distrutto e deportato, perseguitato… tanto che nell’Apocalisse si sostiene che ogni forma di potere viene dal male, che a volte prende le forme di Dio ma è sempre completamente negativo. C’è però, insieme a tanti altri, un brano che si presta a essere riletto con più calma, tanto più che di solito non abbiamo il tempo di soffermarci a considerarlo, perché spesso lo ascoltiamo nel lungo racconto della passione di Luca. Lo troviamo all’inizio del capitolo 23 di Luca. Perché solo in un vangelo? Sto parlando del curioso intreccio per cui Pilato, dopo il primo interrogatorio di Gesù, decide di inviarlo da Erode, che si trovava a Gerusalemme per la Pasqua. La prima curiosità con cui possiamo decidere di fare i conti è che questo brano compare solo nel vangelo secondo Luca. Perché alcuni episodi sono riportati da tutti i vangeli (in realtà praticamente solo la passione, e non in tutti i particolari, appunto), altri dai tre “sinottici” (e sono la maggior parte: stiamo riferendoci a Matteo, Marco e Luca), altri da due o da uno solo? In buona parte non lo sappiamo. È abbastanza chiaro che Matteo e Luca, mentre scrivevano i loro vangeli, avevano davanti il testo di Marco e con tutta probabilità un altro scritto che a noi non è arrivato. In parte, però, hanno anche fonti proprie, esclusive, o almeno scelgono di riportare ciò che per gli altri non è altrettanto interessante. È infatti altrettanto probabile che i materiali a disposizione dei quattro evangelisti fossero molto più ampi di quelli che effettivamente entrano poi a far parte del loro testo. Giovanni lo dice anche esplicitamente, con una certa esagerazione: «Se si scrivessero una per una tutte le cose dette e fatte da Gesù, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere» (Gv 21,25), ma questi segni «sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo e perché, credendo, abbiate la vita» (Gv 20,31). L’obiettivo ultimo della stesura dei vangeli è quindi non tanto la conoscenza di particolari sulla vita di Gesù, ma la fede in lui. Nello scegliere i brani da inserire, però, di certo influiscono anche interessi e sensibilità degli autori. Luca, ad esempio, si svela anche negli Atti degli Apostoli un autore attento al mondo politico e sociale che lo circonda. E infatti ciò che ci dice su un passaggio del processo a Gesù che riferisce solo lui è estremamente verosimile e interessante. La situazione dell’impero Tutti noi sappiamo che al tempo di Gesù in Israele dominava l’impero romano. In realtà questa affermazione è un po’ troppo generica e imprecisa. Noi, infatti, siamo inevitabilmente portati a pensare all’impero romano sul modello degli imperi seicenteschi e settecenteschi, come a un potere estremamente accentratore che ha tutto sotto controllo in un modo molto omogeneo. L’impero romano non era così. Quando si affacciava in un’area nuova, spesso selezionava alcuni centri, non necessariamente i più grandi, ma che si erano affidati a lui o sembravano in qualche modo più affidabili, e questi venivano caricati di maggiore potere e importanza. Altrove si consentiva magari che mantenessero i propri tribunali, o una propria gestione delle tasse, o un’amministrazione in parte autonoma. Il principio era quello del “dividi e comanda”. Se per caso in quella regione si fosse pensato a una rivolta contro Roma, le speranze di successo non avrebbero potuto che derivare dalla compattezza contro un nemico molto forte. Ma, in caso di rivolta, qualcuno avrebbe avuto da perderci più di altri, e di sicuro avrebbe fatto la spia. È un sistema che i romani applicavano in modo generalizzato e con molta astuzia, e che infatti si svelò molto utile ed efficace. Agli amministratori locali l’impero chiedeva sostanzialmente tre cose. La più importante era che garantissero l’ordine pubblico. Se c’era questo, su tutto il resto si poteva discutere. Poi, chiedevano tasse. Infine, e solo se sentivano di potersi fidare, soldati. Ma se trovavano un potere locale che garantiva l’ordine pubblico, normalmente lo lasciavano stare, si assicuravano che non prendesse iniziative di politica estera in contrasto con Roma, e su tutto il resto scendevano volentieri a patti. Nell’area di Israele i romani avevano visto l’ascesa di Erode il Grande, personaggio spietato anche con i suoi stessi figli ma che governava con sicurezza i propri territori, e gli avevano concesso una notevole autonomia, stimandone il polso con cui governava, senza mai mettersi contro Roma. Alla sua morte, dapprima i romani rispettano il testamento di Erode, che divide gran parte del suo territorio tra i suoi tre figli più grandi superstiti, più altri pezzi più piccoli in varie donazioni. Galilea e Gerusalemme La parte più prestigiosa, che comprende Gerusalemme, viene affidata ad Archelao, che però non convincerà i romani, che dieci anni dopo lo depongono e si occupano direttamente della Giudea e Samaria. In realtà applicano anche lì la solita tattica di delega sotto minaccia. Concedono al sinedrio l’amministrazione ordinaria dell’area, fatte salve le condanne a morte che restano di responsabilità romana e gran parte delle tasse; se però qualcosa non fosse andato bene, se ci fossero stati disordini, il sinedrio sarebbe stato ritenuto responsabile (ecco perché tanta ansia anche nei confronti di movimenti non politici come quello di Gesù). I romani mantenevano comunque due coorti in zona, come sorveglianza armata, e un prefetto che rappresenta l’autorità romana. Certo, si trattava di una zona piccola, povera, senza un potere pieno e lontana da Roma; non un posto appetibile per chi puntava alla carriera, e infatti vengono mandati a Gerusalemme prefetti o senza particolari capacità e ambizioni o in castigo. Dal 26 al
Festa della Consolata 2025
La comunità più recente dell’Istituto celebra la prima festa della Consolata: le Sorelle di Urgench, in Uzbekistan, ci regalano una bellissima preghiera di lode insieme alla piccola comunità cristiana! La Consolata ti benedica e ti protegga, buona festa!
Novena alla Consolata: nono giorno
LA CONSOLAZIONE È MISSIONE
Novena alla Consolata: ottavo giorno
LA CONSOLAZIONE È ACCOGLIENZA
Novena alla Consolata: settimo giorno
LA CONSOLAZIONE È SALVEZZA
Novena alla Consolata: sesto giorno
LA CONSOLAZIONE È GIOIA
Novena alla Consolata: quinto giorno
LA CONSOLAZIONE È SPERANZA
Novena alla Consolata: quarto giorno
LA CONSOLAZIONE È UN SEGNO
Novena alla Consolata: terzo giorno
LA CONSOLAZIONE È DIALOGICA, È OFFERTA
Novena alla Consolata: secondo giorno
LA CONSOLAZIONE, UN DONO, IL SUO DONO A NOI
Novena alla Consolata: primo giorno
LA PAROLA CONSOLAZIONE
Inizia la novena a Maria Consolata
Una novena molto cara e importante per la famiglia Consolata, che si raccoglie sotto il manto della Fondatrice e Patrona: la Madonna Consolata
Missione. Il dialogo della vita
L’esperienza dei Missionari della Consolata in Corea del Sud, impegnati nel dialogo interreligioso, che nella quotidianità si traduce nel DIALOGO DELLA VITA