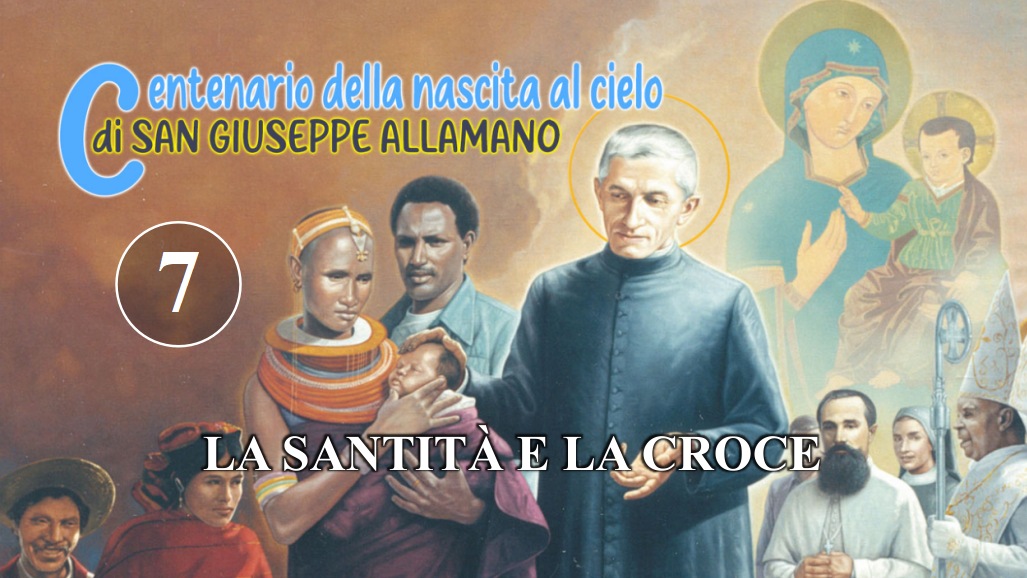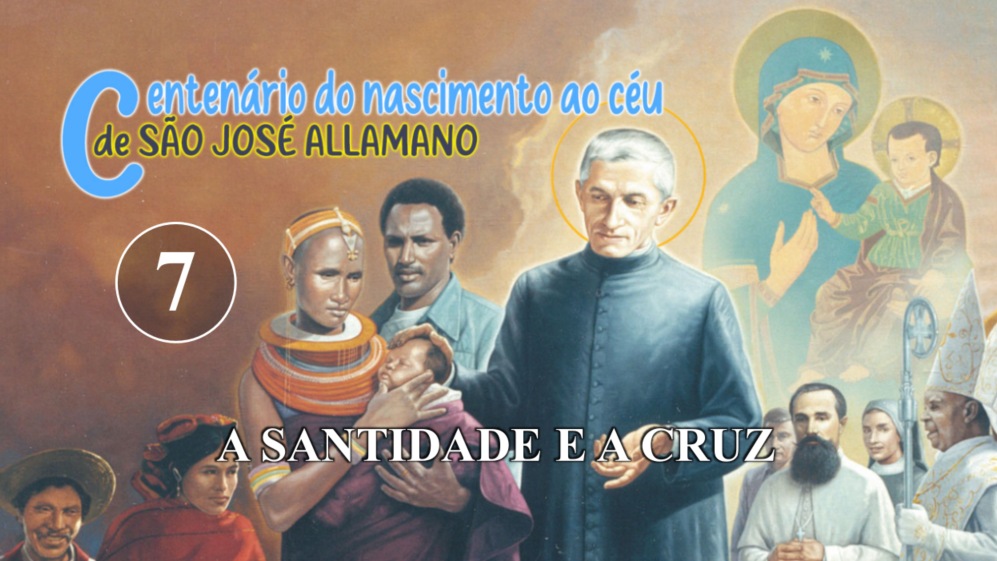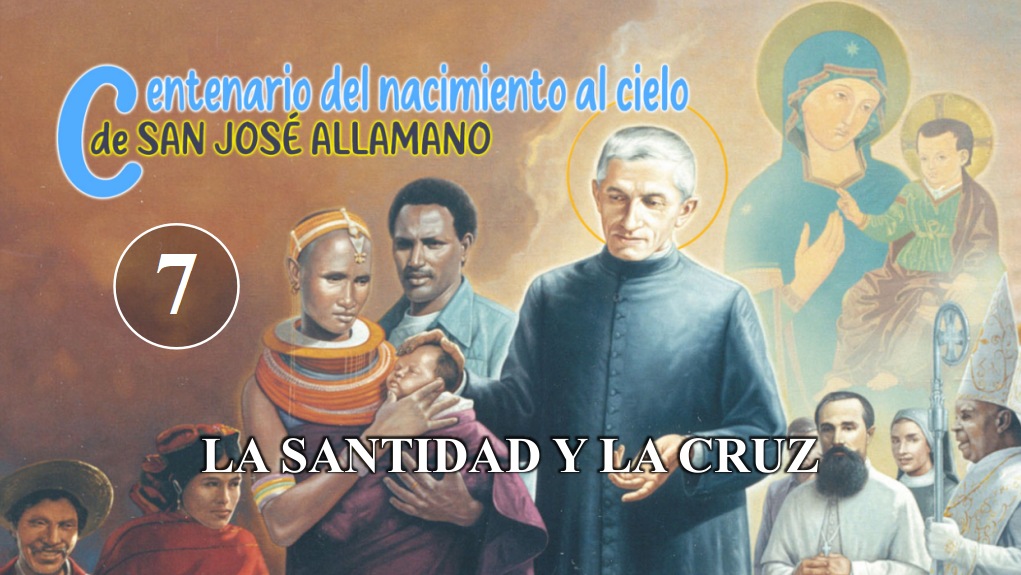I rapporti tra fratelli sono sempre complicati: possono costituire un legame unico e strettissimo oppure altrettanto asfissiante e velenoso. Nella Bibbia sembrano essere rappresentati soprattutto i secondi, a partire dal primissimo rapporto fraterno, quello tra Caino e Abele ma anche con il più famoso esempio di gemelli, Giacobbe ed Esaù, rapporto problematico ma non privo di sorprese.
Nemici da sempre
La madre di Giacobbe ed Esaù, Rebecca, come tante altre matrone bibliche importanti non riesce dapprima ad avere figli, ma quando resta incinta, sente di avere in grembo due gemelli che si fanno la guerra tra di loro. Anche nel parto, Giacobbe, che nasce per secondo, lo fa tenendo per mano il tallone del fratello.
I due resteranno opposti sempre: l’uno, Esaù, il primogenito, è cacciatore, grintoso, peloso, cocco di papà, l’altro è più pigro, almeno da giovane, coltivatore, “tranquillo” (Gen 25,27), cocco di mamma. I due si odiano. Un giorno, mentre Esaù torna da una battuta di caccia sfortunata e trova il fratello che sta mangiando una zuppa, gliene chiede un po’, e l’altro gli risponde di cedergli, in cambio, il diritto alla primogenitura, che comportava di avere il meglio dei beni e, soprattutto, portare l’eredità del nome paterno, benedizione divina compresa. Una richiesta talmente sproporzionata da sembrare una battuta mal riuscita, e in fondo Esaù sembrerebbe aver ragione a ribattere che «se muoio, a che mi serve la primogenitura?» (25,32).
Quando però il padre Isacco si sente venire meno, ricorre a un rito antico (una benedizione da primogenito in cambio di un pasto) chiedendo a Esaù di cacciare e cuocergli un piatto di carne. La madre Rebecca, che ascolta, invita Giacobbe a uccidere uno degli animali del gregge, mentre lei stessa gli prepara il piatto e lo invita a tenere la pelle di un capretto sulle braccia perché il padre, ormai quasi cieco, venga ingannato, pensando di trovarsi davanti al peloso Esaù anziché al glabro Giacobbe.
L’inganno funziona e Isacco benedice il secondogenito, per la disperazione del fratello quando finalmente arriva a casa. Tanto è vero che la sua decisione è esplicita ed estrema: «Aspetto che muoia mio padre, per non dargli un dolore, e poi ucciderò mio fratello» (Gen 27,41).
È questo il motivo per cui la madre manderà Giacobbe dallo zio Labano, dove il giovane diventerà uomo, guadagnandosi due mogli e, con un inganno abbastanza sofisticato, greggi e mandrie forti e selezionate, oltre a schiavi e figli. Solo a quel punto deciderà di provare a tornare nella terra di Canaan, dove vive suo fratello.
L'Esaù che non ti aspetti
Non è insomma difficile capire che Esaù è il cattivo della storia. D’altronde, molto spesso i racconti biblici ci presentano i personaggi non in sé, ma per ciò che rappresentano: i patriarchi non sono semplicemente degli uomini storici, ma la tribù a cui si presume che abbiano dato origine. Quando si parla di Giuda, non si intende solo o tanto uno dei figli di Giuseppe, ma la tribù da cui è nato anche il re Davide.
Ebbene, Esaù, che prenderà anche il nome di Edom (Gen 25,30), è il capistipite degli idumei, quella popolazione residente a sud del territorio di Giuda, nel deserto, da dove di tanto in tanto cercherà di espandersi verso nord, a volte riuscendoci, come dopo la distruzione di Gerusalemme, tanto da attirarsi le feroci polemiche che leggiamo in alcuni profeti (Mal 1 e l’intero libriccino di Abdia).
Questo stesso giudizio negativo, peraltro, si mantiene nella valutazione cristiana, che copia semplicemente la condanna di Esaù (così anche san Paolo: Rom 9,13, senza però approfondire l’analisi) o la usa come esempio di chi non sa valorizzare il bene che ha a disposizione (Eb 12,16).
Nonostante questo, le azioni di Esaù ce lo presentano in una luce diversa. Veniamo infatti a sapere, di passaggio e prima della benedizione di Isacco al primogenito, che Esaù ha sposato delle donne “ittite”, verosimilmente trovate nella terra di Canaan (Gen 26,34), che non vanno a genio ai suoi genitori.
Sembra un’annotazione secondaria, destinata ad essere dimenticata. Eppure, dopo la vicenda della primogenitura rubata, Esaù si rende conto che i suoi matrimoni non sono graditi ai genitori e aggiunge un’altra moglie più presentabile (Gen 28,8). Perché lo fa? Da una parte, ci si aspettava che un buon figlio rispettasse il volere del padre di famiglia. Ma Esaù sembra non curarsene finché potrebbe anche averne un vantaggio, per poi invece preoccuparsene quando la benedizione da primogenito gli è ormai stata sottratta. Spera forse di far cambiare idea al padre? È difficile immaginarlo, perché suo padre, che pure voleva privilegiare lui, dichiara di non poter mutare nulla della benedizione che ha formulato (Gen 27,38-40).
L’impressione è quindi che il duro e burbero Esaù voglia comunque evitare di rattristre i suoi genitori, anche se ormai non dipende da loro e benché possa a buon diritto lamentarsi almeno del comportamento di sua madre.

La grande svolta
C’è però altro che bolle in pentola.
Tanti anni dopo la sua fuga da Canaan per salvarsi, infatti, Giacobbe decide di ritornare da dove era venuto, principalmente per scappare dal suocero.
Certo, si ricorda che suo fratello si era ripromesso di vendicarsi, ma può sempre sperare che il tempo abbia fatto dimenticare le ragioni di una spietata inimicizia fraterna.
La Genesi non ci dice nulla dei pensieri di Esaù, si limita a raccontarci le sue azioni: va incontro a Giacobbe accompagnato da quattrocento uomini armati. Non è difficile capire le sue intenzioni.
Giacobbe si comporta ancora una volta da uomo sicuramente astuto ma anche senza scrupoli: divide la sua gente in due, sperando che Esaù attacchi un gruppo e lasci in pace l’altro. In quanto a sé, sceglie di restare dietro, nelle retrovie, per rischiare il meno possibile. Sa che suo fratello ce l’ha solo con lui, e cerca di nascondersi.
Quando però arriva al confine con la terra di Canaan deve decidere se passare uno uadi, torrente d’acqua dalla portata molto incostante che scava una profonda fenditura nella roccia, tanto che per chi fugge si trasforma in una trappola, perché potrebbe essere diventato non guadabile, gonfiato da piogge anche lontanissime da lì, e comunque ti tiene per tanto tempo a portata di freccia di chi ti insegue. Se Giacobbe lo attraversa, rischia di non poter tornare più indietro, di non riuscire più a scappare. Ma se non lo fa, perde di certo mogli e figli, oltre a tutti i suoi beni. La Bibbia ci racconta l’angoscia di quella notte e di quella decisione parlando di una lotta di Giacobbe con un angelo di Dio, al termine della quale non c’è un vincitore, anche se Giacobbe non riesce a farsi dire il nome del suo avversario (come garanzia di non esserne maledetto).
Lì, però, impara a fidarsi, di Dio e degli uomini, inizia a cambiare il suo modo d’essere.
Sì, ma che cosa gli succederà? Il libro della Genesi resta asciutto ma si fa commovente. Esaù, infatti, sembra non essersi accorto dei doni che il fratello gli aveva inviato nei giorni prima per ammorbidirlo. Sa quindi che il fratello ha avuto fortuna, e potremmo immaginare che tutta quella folla che sta arrivando sia destinata ad andare schiava dei suoi quattrocento soldati.
E invece Esaù arriva davanti al fratello e, prima di ogni altra cosa, lo abbraccia, lo bacia e piange. Come il padre del figlio prodigo della parabola di Gesù!
Solo dopo si informa su chi sia tutta quella gente, e non pretende nulla. Si offre invece di accompagnarlo nella nuova terra, anche se Giacobbe, che è diventato capace di fidarsi degli altri ma ancora mantiene un po’ del suo uomo vecchio, accampa scuse per mandare il fratello via da solo…
Un senso?
Tante narrazioni esigerebbero forse semplicemente di essere raccontate e non spiegate, per lasciare al lettore di tirare fuori il senso di ciò che ha letto.
Potremmo però dire che già dall’inizio troviamo nella Bibbia la consapevolezza che anche coloro che riteniamo cattivi siano in realtà capaci di gesti di grande umanità, forse ancora più rilevanti perché non accompagnati dalla promessa o dalla ricompensa divina. Il pessimo Esaù, il figlio gemello cattivo, si mostra in realtà capace di gesti di attenzione gratuiti e generosi.
Non sappiamo come abbia pagato i suoi quattrocento armati, ma sappiamo che la sopravvivenza di Giacobbe, dei suoi figli e dei suoi discendenti è anche merito suo. Benché spesso non gli venga attribuito…