
Sr. Marzia Feurra ci ha lasciato improvvisamente il 1° maggio 2022 a Gibuti. Donna per le donne, somala con i somali, infermiera, sarta, ma sempre sorella cristiana tra fedeli musulmani: queste le coordinate dei suoi 60 anni di vita religiosa, tutti spesi ai 45° all’ombra nel Corno d’Africa. Da un’intervista rilasciata nel 2019 a Paola Aversa, della Caritas di Roma.
Quando è iniziata la vostra presenza in Somalia?
La nostra congregazione aprì la sua prima missione a Mogadiscio nel 1925. Ci occupavamo soprattutto di orfani, istruzione e salute, creando nel tempo scuole e ospedali. Io arrivai a Mogadiscio nel ’67, e tutto filò liscio fino al ’69, quando arrivò al potere Siad Barre. Nel ’72 il governo decise la nazionalizzazione di ogni attività privata: requisirono le missioni e ci posero sotto il controllo di funzionari governativi. Nel lavoro con i bambini ci furono affiancate ragazze somale, allo scopo di far “imparare il mestiere” per poi allontanare noi suore dal territorio. Dopo un mese, venne a farci visita il vice presidente, Hussein Kulmie. Dopo averlo ascoltato, le ragazze dissero che sarebbero rimaste solo se noi fossimo restate con loro. Intanto, anche il nunzio mons. Calabresi riuscì a convincere le autorità della bontà dell’operato nelle missioni e ad ottenere di poterne conservare quattro (Afgoy, Merka, Kisimayo e Gilib).
Continuammo la nostra opera con bambini e adolescenti, sotto le direttive e la supervisione di quadri locali: pur non ricevendo nessun salario eravamo di fatto delle loro dipendenti. La situazione peggiorò decisamente all’inizio degli anni ’90. Già nel luglio dell’89 era stato ucciso il vescovo di Mogadiscio, mons. Colombo. Si preparava la guerra civile, le bande armate impazzavano per le strade. C’era scarsità di ogni tipo di beni, i prezzi aumentavano e con essi il malcontento. Nel ’91 Siad Barre fu estromesso dal potere dal suo Ministro della Difesa, generale Mohamed Farah Aidid, e si aprì una dura lotta tra i vari “signori della guerra”, a capo di clan e fazioni rivali, che diede il via ad una sanguinosa guerra civile (in atto fino ad oggi, ndr).
Nel gennaio del ’91 erano presenti a Mogadiscio solo più alcune suore e tre religiosi, tra cui p. Giorgio Bertin (oggi Vescovo di Gibuti e amministratore apostolico per la Somalia). Nella capitale non si era più al sicuro perché si sparava per strada e i miliziani entravano dappertutto, saccheggiando e uccidendo. Ormai non potevamo più restare e avevamo solo due possibilità: fuggire raggiungendo l’aeroporto o rifugiarci nell’ambasciata italiana; entrambe le mete erano distanti e si trattava di attraversare Mogadiscio sotto il fuoco delle armi e le bombe.

Come riusciste a fuggire?
In queste situazioni la gente del posto ci ha sempre aiutato. Un uomo somalo si è offerto di accompagnarci all’ambasciata italiana. Eravamo una decina di suore e di mattina presto, quando era ancora buio, lasciammo la missione a piedi, portando con noi la Bibbia e pochissime cose. Lo seguimmo, facendo un percorso tortuoso lungo strade e quartieri periferici, meno colpiti dai combattimenti. Quando l’ambasciata fu vicina ci lasciò, ma subito fummo fermate da militari che ci puntarono i mitra contro. Io, che parlo il somalo, mi avvicinai per dialogare col comandante e lo convinsi a lasciarci raggiungere l’ambasciata. Lui fece di più: ci fece scortare fin là.
E poi?
Espressi all’ambasciatore la mia preoccupazione per le altre suore rimaste in città; lui mi sconsigliò di andare loro incontro, dicendo che bisognava attendere un’evacuazione più sicura. Insistetti. Mise a disposizione una macchina con un autista somalo. Durante il viaggio sventolavo un asciugamano bianco, come se stessimo trasportando un ferito. Riuscimmo a passare i posti di blocco fino a raggiungere le consorelle, le quali, vivendo in periferia, non erano del tutto consapevoli del pericolo. Riuscimmo a tornare in ambasciata altrettanto fortunosamente. C’era però ancora una comunità di sorelle anziane a rischio, rimaste chiuse in casa e impaurite, bloccate sia fisicamente che psicologicamente.
Questa comunità era in una zona “calda”, controllata dalle milizie ribelli anti governative, molto pericolosa. L’ambasciatore questa volta ci negò sia la macchina che l’autista, troppo rischioso! La mattina dopo, verso le cinque, quando ancora i combattimenti non erano ripresi, io e una consorella lasciammo l’ambasciata italiana a piedi per raggiungere le sorelle. I governativi ci bloccarono, impedendoci di proseguire, perché, dicevano, le milizie nemiche ci avrebbero ucciso. Insistetti, spiegando che dovevamo andare urgentemente in ospedale per assistere delle suore malate.
Dopo qualche tira e molla ci fecero passare. A poche centinaia di metri di distanza dalla missione ci fermarono anche i ribelli: non credevano ai loro occhi e, forse addirittura divertiti dalla nostra “follia”, ci fecero passare senza torcerci un capello. Immediatamente, una di noi si mise alla guida del pulmino e un’altra si sistemò sul sedile anteriore fingendo di essere gravemente malata. Partimmo di corsa sventolando il solito panno bianco e attraversammo Mogadiscio in guerra senza che nessuno ci fermasse o ci sparasse, raggiungendo infine l’ambasciata.
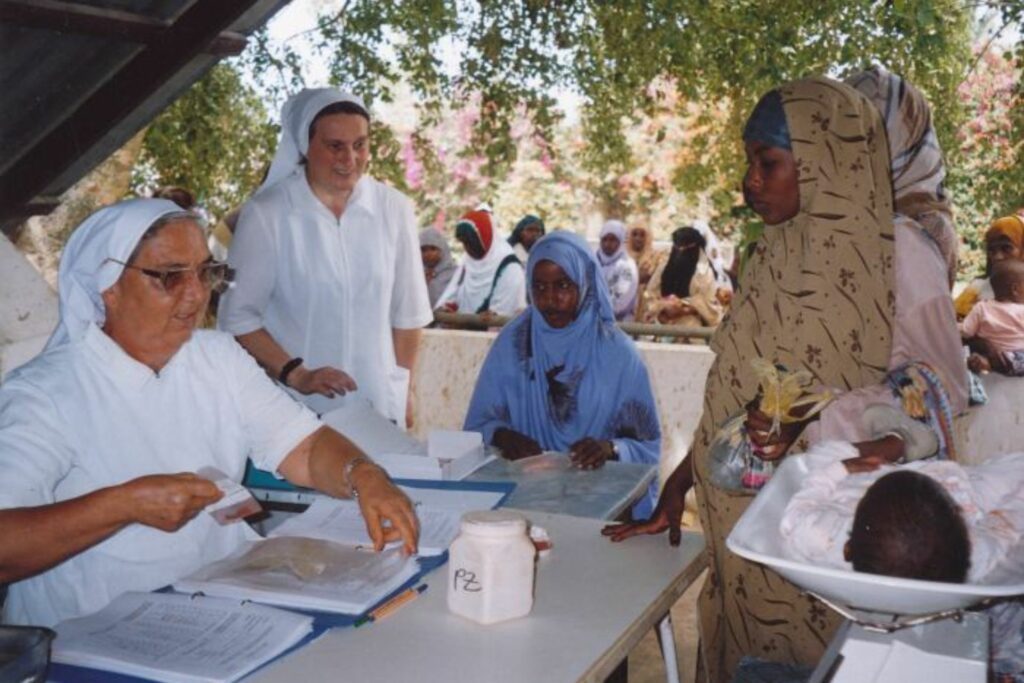
Poi foste tutti evacuati dalla Somalia?
Nel novembre 1991, l’ambasciata e il governo italiano riuscirono a organizzare l’evacuazione da Mogadiscio, ma tre di noi, tutte infermiere, rimasero in Somalia, a curare i feriti con Medici senza Frontiere. Poco dopo, episodi di minacce indussero MSF a evacuare il personale. Nel marzo del 1992 tornai a Mogadiscio al seguito di SOS, una organizzazione che aveva un ospedale pediatrico, dove lavorai fino al 2006, quando fu uccisa suor Leonella Sgorbati. Mogadiscio rimaneva comunque un posto molto pericoloso… Finché la guerra era tra le varie fazioni e tribù e tra i vari signori della guerra, noi suore non ci sentimmo mai minacciate direttamente. Certo, c’erano proiettili e bombe che cadevano e potevamo essere colpite, ma non eravamo un bersaglio. Le cose sono cambiate quando sono arrivati i fondamentalisti: siamo entrate nel mirino in quanto cristiane e in quanto religiose.
Tant’è che lei fu vittima di un sequestro.
Accadde nel 1998. Rimasi nelle mani dei miliziani per tre giorni e due notti. Mentre tornavo a casa dal lavoro, a Mogadiscio, mi si affiancò una macchina e degli uomini armati mi scaraventarono dentro con la forza. Mi portarono in una casa, da qualche parte in città, dove mi rinchiusero in una stanza vuota, solo una stuoia a terra. Dai discorsi dei miei rapitori capii che il loro scopo era ottenere un riscatto. Spiegai che non avevo fatto nulla di male, che anzi da tanti anni curavo i loro bambini, i loro malati! Mi fecero capire che non avrebbero rinunciato al denaro.
Qual era il suo stato d’animo in quella situazione?
La cosa strana è che, dopo un primo momento di paura, nelle ore successive rimasi assolutamente tranquilla, come se ciò che mi stava capitando fosse normale. Qualunque cosa mi dicessero, rispondevo in somalo, sempre in modo garbato. Volevo tenerli calmi, non volevo contrariarli. La prima notte avevano anche mandato una donna a farmi compagnia. La seconda notte, invece, ebbi paura, perché rimasi da sola con dieci uomini armati, drogati dal khat che masticavano in continuazione. Mi chiedevo se e come avrei potuto uscirne viva, mi sforzavo di rimanere lucida, ma non riuscii comunque a chiudere occhio.

Come avvenne la sua liberazione?
Non sapevo che la voce del mio rapimento si era sparsa tra le mamme dei bambini in cura all’Ospedale, e che erano scese in strada a Mogadiscio gridando per la mia liberazione, in un corteo improvvisato. Non sapevano dove fossi rinchiusa; i miei sequestratori mi avevano tolto il velo e fatto indossare un burqua, così che non potessi essere riconosciuta, ma per le donne, fini osservatrici, non fu difficile raccogliere un po’ di voci e di informazioni e scoprire dove mi trovassi. Si diressero allora tutte insieme dove ero prigioniera, accerchiando la casa e reclamando la mia liberazione. Sfidavano i miliziani armati dicendo che non se ne sarebbero andate finché non avessero liberato la “loro” suora. I soldati cominciavano a essere infastiditi, e provarono un paio di volte, di notte, a spostarmi in un altro luogo, senza riuscirci, perché le donne presidiavano l’uscita. Io ero impotente, aspettavo solo di conoscere la mia sorte. La mattina del terzo giorno venne la madre di uno dei carcerieri, che apostrofò il figlio in malo modo, dicendogli che si vergognava di lui e ingiungendogli di lasciarmi libera. La donna iniziò a urlare e a stracciarsi le vesti, mettendosi di fronte a me e dicendo che se volevano uccidermi avrebbero dovuto uccidere prima lei. Qualche ora dopo, altre andarono a cercare un anziano molto influente, una specie di saggio o “santone”, perché intercedesse per la mia liberazione. Questi iniziò a parlare con i rapitori citando brani del Corano, e chiedendo di liberarmi. Alla fine, dopo una lunga e accesa discussione, accettarono. Quando uscii dalla porta della mia “prigione”, non potevo credere ai miei occhi; dall’interno non avevo capito la portata di quello che stava accadendo fuori: c’era gente a perdita d’occhio che gridava di gioia, esultava, ballava e cantava. Quasi non riuscivamo a muoverci per la folla che circondava la macchina. In tutta questa vicenda, è stato il momento più bello, la mia “Pentecoste”. La gente festante, la gioia di così tanti musulmani per… una suora!
Dopo questa esperienza ha continuato a lavorare a Mogadiscio?
Ho continuato come prima, fino al 2006. Purtroppo dopo l’assassinio di Suor Leonella non è stato più possibile rimanere a Mogadiscio e in Somalia: era troppo pericoloso e per di più inutile, perché non potevamo più fare nulla per quella gente. Tutto è andato perduto o distrutto.
Come avete fatto a resistere alla guerra in quegli anni? E perché è stata uccisa suor Leonella?
La prudenza era il solo modo per sopravvivere. Abbiamo attraversato 16 anni di guerra feroce: davvero la mattina non sapevamo se saremmo arrivate vive alla sera, ma siamo riuscite a barcamenarci, a non esporci, a non schierarci in quella confusione di bande, tribù e fazioni che imperversavano e ancora imperversano in Somalia. Quando la superiora generale ci chiamava, preoccupata per la situazione, e ci chiedeva se non volessimo andar via, metterci al sicuro, noi rispondevamo che volevamo restare. Ci incoraggiava e ci assicurava che ci sarebbe stata vicina qualunque fosse stata la nostra decisione. Ci diceva: “Chiedete alla vostra gente, sentite loro, e poi decidete!”. Nella difficoltà, noi prendevamo la Bibbia e cercavamo la luce nella preghiera e nella parola del Signore, e l’abbiamo sempre trovata: la parola di Dio ci dava il coraggio. Alla fine eravamo sempre d’accordo di rimanere con i nostri bambini, con i nostri anziani, con coloro che avevano bisogno di noi. La morte di suor Leonella arrivata come un fulmine a ciel sereno. Lei lavorava con 800 bambini malati di TBC: tutti sapevano cosa facevamo lì, e tutti ci dimostravano affetto, ma ciò non ha impedito che quel 17 settembre del 2006 sr. Leonella venisse assassinata. Ogni giorno i kamikaze uccidevano civili innocenti, è vero, ma ogni volta che c’era sentore di qualche movimento strano, qualcuno ci metteva in guardia sempre, suggerendoci di non uscire o di evitare certe strade. La gente in fondo era con noi, la popolazione di Mogadiscio è pacifica e generosa e ci ha sempre aiutato nei momenti difficili. Ci dicevano che finché fossimo rimaste, per loro era ancora accesa la luce della speranza. Purtroppo non è stato possibile.